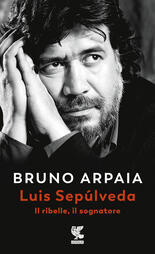In libreria "Tra una vita e l'altra", raccolta di racconti di autori italiani e irlandesi, curata da Catherine Dunne, che mostra cosa hanno in comune Italia e Irlanda, "paesi adorati e spesso abbandonati, nel passato come nel presente". Su ilLibraio.it pubblichiamo uno dei brani inediti, "Liverpool/Lampedusa" di Liz McManus
Arriva in libreria per Guanda Tra una vita e l’altra, raccolta di racconti curata da Catherine Dunne, che narra la storia di due paesi, l’Italia e l’Irlanda, adorati e spesso abbandonati, nel passato come nel presente. Quindici autori, italiani e irlandesi, raccontano il senso di estraniamento, la sensazione di non appartenenza che viene da un vissuto comune di distacco e migrazioni incrociate. Il risultato è un’antologia che riunisce molte personalità diverse, in cui sono raccolte storie liriche o dure, storie che fanno sorridere e riflettere, storie d’amore e storie in cui la mancanza d’amore anestetizza, rendendo simili ad automi: dal mistero di un bambino cinese scappato da scuola nella Roma di oggi, ai travagli degli emigranti irlandesi nell’Ottocento, in fuga verso un Nuovo Mondo totalmente sconosciuto, dalle avventure di una cameriera italiana a Hong Kong, al difficile rapporto tra una ragazza inglese e un ragazzo irlandese a Dublino negli anni Settanta.
Su ilLibraio.it uno dei racconti (per gentile concessione di Guanda):
Liverpool/Lampedusa
di Liz McManus
Nell’estate del 1850 padre Hore fece un sermone nella chiesa di Kilaveny. Veniva da Coldblow, nella diocesi di Our Lady’s Island, uno sconosciuto nel nostro paesino, eppure la sua reputazione l’aveva preceduto. Quella domenica la gente accorse da ogni dove per ascoltarlo. In seguito un infiltrato della polizia disse di aver contato in tutto duemila anime. In chiesa c’era una tale folla che temetti di non sentire neanche una parola ma, quando attaccò la predica, padre Hore parlò con una voce forte e sincera, che risuonò come una campana fra le travi.
Cominciò dicendoci perché intendeva lasciare il nostro sventurato paese, afflitto da fame e desolazione. Poi chiese a ciascuno di noi di seguirlo nel suo viaggio in America.
«È un mondo nuovo» disse «dove la terra è di tutti, non c’è da pagare alcun canone […] e ogni uomo può pregare il suo Dio nella forma che vuole senza incorrere nell’ostilità dei fratelli, come purtroppo accade troppo spesso qui, dove Dio e le Sue Scritture vengono trasformate in motivo di ostilità e odio invece che d’amore.»*
Riflettei sulle sue parole. Era vero, vivevamo nella morsa di un’enorme sciagura. Su tutto regnava il tanfo dolciastro del carbone: anche quell’anno i campi dissodati intorno a Shillelagh si erano anneriti ed erano morti. Ovunque imperversava la carestia. Io stesso avevo visto con i miei occhi una donna riversa sul ciglio della strada, senza vita, la bocca chiazzata del verde dell’erba. Il cuore mi si era gonfiato di dolore. Un anno prima la mia cara moglie era morta di parto ed ero rimasto solo con l’unico figlio superstite. Madre morta, neonato morto: sia fatta la volontà di Dio.
I tanti che facevano affidamento sulle patate stavano morendo di fame. Io ero fortunato: grazie all’orzo che cresceva nel mio campo avevamo qualcosa da portare a tavola. Quanto sarebbe durato, mi chiedevo? Le calamità rendono codardo chiunque: temevo che la malattia e la morte non avrebbero mai smesso di accumularsi nei quattro angoli dell’Irlanda.
Avevo scelta, eppure non era affatto una scelta. Vendetti i miei beni e mi preparai a seguire il prete. La nostra destinazione era lo stato dell’Iowa, ci disse. Suonava come il ritornello di una canzone: I-o-wa… Per prima cosa, ci informò, saliremo a bordo di un traghetto diretto a Liverpool, dove una nave aspetta per portarci oltreoceano.
E così, a ottobre, mi ritrovai sul ponte del traghetto circondato dai parrocchiani che, come me, avevano scelto di affidarsi a Dio e a padre Hore. Nel guardare i monti Wicklow scivolare sotto l’orizzonte – l’ultima immagine della nostra terra – mio figlio gridò per l’entusiasmo.
Io sentii la gola chiudersi per il dolore e mi voltai temendo di scoppiare a piangere.
Non avevo mai visto una città come Liverpool. Piena di chiasso e fango, imponente, era popolata da farabutti e ladruncoli. In ogni strada aspettavano di imbrogliare e derubare i viaggiatori ingenui. Attraversato il pontile ci fermammo sbalorditi alla vista di tante navi e piroscafi che navigavano nel grande fiume, ma il terrore di quelli che se ne stavano in agguato negli angoli bui e nei vicoli ci impedì di trattenerci. Come il Buon Pastore, padre Hore ci guidò fino alla pensione dell’amico, il signor Sable, un uomo onesto, scoprii con mio grande sollievo, fra tutti quei furfanti.
Quella sera, quando ci sedemmo a tavola per la cena, eravamo già proiettati su quanto ci aspettava. Nel buio, chissà dove, la Ticonderoga veniva ormeggiata al molo Prince e svuotata delle balle di cotone, dei barili di farina e delle novemila doghe che aveva portato dall’America. Il giorno dopo sarebbe stata riempita con un nuovo carico: centinaia di uomini, donne e bambini pronti – per quanto si possa esserlo – a intraprendere il viaggio verso ovest fino a New Orleans.
Sulla cena aleggiò la malinconia finché la porta della sala da pranzo si aprì ed entrò un marinaio. Dall’accento capimmo che era forestiero. Aveva occhi allegri, carnagione olivastra e un corpo grinzoso e ricurvo come la quercia da sughero che cresce nel camposanto di Shillelagh e quando parlava gesticolava in un modo che trovammo comico. Era di Roma, ci disse, dove viveva il suo Santo Padre, il papa. Dopo aver passato tutta la vita in mare, aggiunse, camminare sulla terraferma gli faceva girare la testa. Dal canto mio, pensai che la causa più probabile fosse l’ingente quantità di vino che beveva.
Poiché qualunque distrazione dai nostri pensieri era ben accetta, gli facemmo posto a tavola con entusiasmo.
Dividemmo con lui quanto ci restava nel piatto. Con nostra grande gioia, in cambio il marinaio ci regalò varie storie: di tesori nascosti negli abissi, di mostri marini e di una bella fanciulla che aveva visto una volta, con la coda di pesce. Quando i tavoli vennero sparecchiati e si fece tardi, lui smise di parlare e s’intristì. Pianse anche un po’ e la smise solo quando gli riempimmo di nuovo il boccale di vino.
Lo implorammo di continuare e infine lui accettò, ma stavolta parlò in tono serio e le storie che ci raccontò mi fecero gelare il sangue: storie di poveri migranti dispersi nell’oceano Atlantico e nel mar Mediterraneo, di barconi naufragati durante le burrasche al largo di Lampedusa.
Quella notte, mentre dormivo, venne a trovarmi mia moglie. O almeno così immaginai.
Nel sogno una folla di migranti, fra cui lei, si stringeva sul ponte di un barcone. Lontano, dal mare scintillante, spuntavano alte scogliere minacciose. Il barcone andava alla deriva verso il pericolo. Gridai per avvisarli, ma si sentì solo il risucchio delle onde che si rincorrevano verso l’orizzonte.
Calò la sera e sulla cima della scogliera cominciarono a risplendere le luci. Il barcone, pieno di passeggeri, prese a ruotare su se stesso fra le onde che s’infrangevano sugli scogli sottostanti. Nel disperato tentativo di attirare l’attenzione, qualcuno sul ponte diede fuoco a una coperta. I passeggeri corsero verso il fianco per sfuggire al fumo e alle fiamme. Il barcone ondeggiò, s’inclinò e affondò, e le onde sommersero il carico. Nel sogno sentii urla di uomini e donne, vidi bocche riempirsi d’acqua, braccia supplicare il cielo, ma a me stavano a cuore solo due di loro: la mia adorata moglie e mio figlio appena nato. Mentre sprofondavano negli abissi il cordone ombelicale li univa ancora, una spirale ingarbugliata come un’alga alla deriva. All’inizio della vita, l’imminenza della morte.
L’attimo prima di annegare la donna girò il viso verso di me e io mi resi conto di essermi sbagliato. Non era mia moglie. Era una straniera, diversa da qualsiasi donna avessi mai visto: aveva la pelle nera come il carbone, le guance butterate e graffiate, gli occhi due laghi insondabili e una nuvola di ricci ribelli attorno alla testa. Mentre le onde si chiudevano su di lei, la sua voce squarciò l’aria della notte. Gridò una sola parola: Lampedusa…
Mi sveglia il pianto di mio figlio che dorme accanto a me. Il silenzio della notte e i suoi gemiti scompigliano a tal punto tempo e spazio che mi ritrovo ancora una volta nella vecchia casa accanto alla chiesa di Kilaveny. Prendo dolcemente il bambino fra le braccia e lo cullo fino a farlo riaddormentare. Chiudo gli occhi e cerco di dormire anch’io, senza però riuscirci. Resto sveglio nella soffitta di una pensione di Liverpool in attesa che spunti un nuovo giorno. Il mio unico pensiero è dire una preghiera per lei: la donna del sogno che non è mia moglie. Siamo tutti una cosa sola – prego – che periamo lungo il viaggio o sopravviviamo per raccontarlo.
* Citato in A Farewell to Famine di Jim Rees. (N.d.T.)
L’APPUNTAMENTO A MILANO – Lunedì 23 novembre, alle ore 17.30, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Aula Cripta, in Largo A. Gemelli), verrà presentato il volume. Introduce: Enrico Reggiani; Intervengono: Catherine Dunne, Valerie Bistany e Federica Sgaggio. Letture: Noel Monahan, Gaia Cenciarelli e Fabio Bussotti.
Fonte: www.illibraio.it