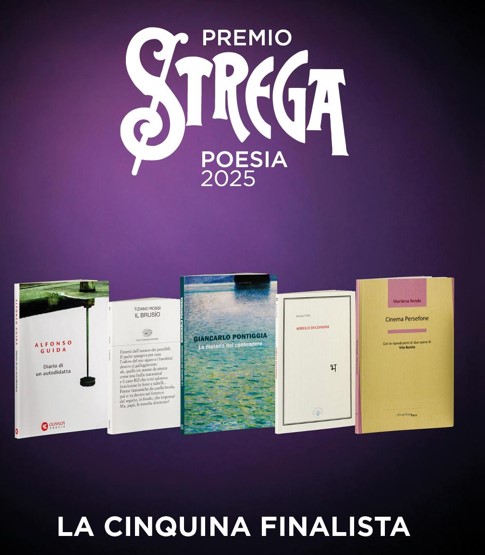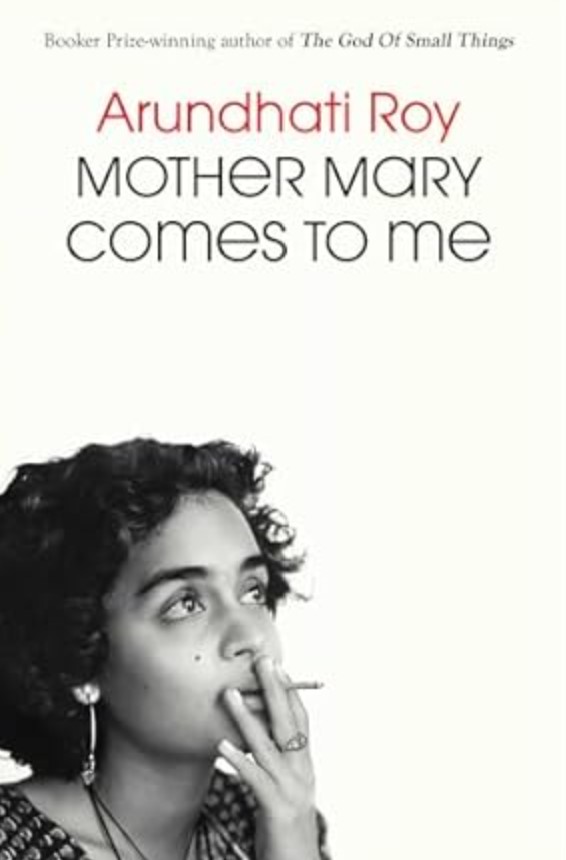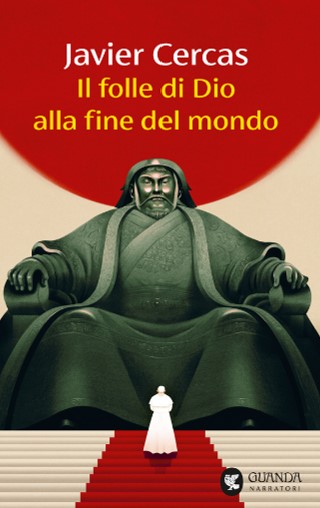Una filosofia di vita? Un’arte? Una necessità? Probabilmente il concetto di leggerezza risponderebbe bene a tutt’e tre queste definizioni, fondamentale com’è in un mondo che tende sempre di più a correre, a prendersi sul serio e ad appesantirci con mille pensieri.
Non per niente, del resto, è da secoli che scrittori e scrittrici di ogni dove si interrogano sulle sue caratteristiche, cercando di afferrarla e di darle una forma senza però spezzarne l’incanto. Perché a evocarla basta poco, certo, ma rimane poi altrettanto facile rendere la leggerezza un’artificiosa caricatura di sé stessa.
SCOPRI LA SEZIONE “CITAZIONI” DEL NOSTRO SITO
Dalle parole di Apuleio a quelle di Jerome K. Jerome, passando per Marina Cvetaeva e per Milena Jesenská, ecco quindi una selezione di alcune fra le più belle frasi sulla leggerezza tratte dalla letteratura, per riscoprirne il valore intrinseco e tornare a considerarla una parte integrante della nostra quotidianità…
Frasi sulla leggerezza tratte dalla letteratura
Cominciamo da una frase tratta da Tutto è vita (Guanda, a cura di Dorothea Rein) della giornalista, autrice e traduttrice ceca Milena Jesenská (1896-1944), che ci aiuta a far luce su un aspetto fondamentale: calcare la mano sulla leggerezza sarebbe un errore, tanto quanto pretendere che sia l’unico principio in grado di guidare le nostre azioni, anche se prenderla in considerazione al momento giusto può davvero fare la differenza…
Prendere sul serio la leggerezza è di cattivo gusto. Ma assaporare la leggerezza senza lasciarsene prendere la mano è una forma superiore di vita.
A rendere ancora più esplicito questo punto di vista è stato lo scrittore, poeta e filosofo francese Paul Valéry (1871-1945), che nell’opera Tel quel (it. Tal quale), pubblicata nel 1943, ha evidenziato la differenza fra leggerezza e superficialità con una doppia similitudine, sintetica eppure al tempo stesso estremamente efficace, che potremmo considerare una massima universale di comportamento:
Bisogna essere leggeri come un uccello e non come una piuma.

Dal paragone con il librarsi in cielo passiamo ora a uno più legato al mondo marino, un famoso passo sulla leggerezza contenuto nel romanzo Tre uomini in barca (Garzanti, traduzione di Alba Bariffi) di Jerome K. Jerome (1859-1927). Qui infatti, lo scrittore, giornalista e umorista britannico ci ricorda che non ha senso sovraccaricarci di aspettative, pulsioni e desideri, e che una vita leggera è spesso una vita più felice:
Liberatevi della zavorra, uomini! Lasciate che l’imbarcazione della vostra vita sia leggera, carica soltanto di quello di cui avete bisogno: una casa accogliente e qualche semplice piacere, un paio di amici degni di questo nome, qualcuno da amare e che vi ami, un gatto, un cane, e una o due pipe, cibo e indumenti a sufficienza e da bere in abbondanza, perché la sete è una compagna pericolosa.
Dopotutto, lo sosteneva già nel II secolo l’autore latino Apuleio (125-180 circa) nell’opera apologetica Della magia (Garzanti, traduzione di Concetto Marchesi), evidenziando che anche nelle situazioni meno liete possiamo restare a galla se evitiamo i pesi inutili, trovando proprio nella leggerezza una strategia di sopravvivenza, un salvagente, un modo per non perdere di vista l’essenziale e tornare gradualmente a prendere fiato:
Per vivere, proprio come per nuotare, va meglio chi è più privo di pesi, ché anche nella tempesta della vita umana le cose leggere servono a sostenere, quelle pesanti a far affondare.

E concludiamo con una frase della celebre scrittrice e poetessa russa Marina Cvetaeva (1892-1941), che in una lettera a Myroslav Yurkevich del 1916 associò questo termine a un senso più ampio e più profondo di benessere personale e interpersonale, fatto di rispetto reciproco, di autodeterminazione e di ascolto, che non potrebbero coesistere senza il collante di una leggerezza consapevole ed empatica:
Io voglio leggerezza, libertà, comprensione − non trattenere nessuno e che nessuno mi trattenga.
E quella famosa frase di Italo Calvino?
Prendete la vita con leggerezza, ché leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore.
Probabilmente sarà capitato anche a voi, una volta o l’altra, di imbattervi anche in questa frase sulla leggerezza attribuita allo scrittore italiano Italo Calvino (1923-1985), ma sapevate che in realtà si tratta di una citazione che non figura nel volume Lezioni americane (Mondadori) al quale viene associata?
Nel febbraio 2022 la giornalista Alessandra Chiappori ci ha tenuto a segnalarne l’attribuzione errata, riprendendo un commento del 2018 che era stato pubblicato sulla piattaforma X (ex Twitter) dalla stessa figlia dello scrittore, Giovanna Calvino, in risposta a un post.
In ogni caso, di per sé, le sei proposte per il nuovo millennio concepite dall’autore in vista di un ciclo di lezioni che avrebbe dovuto tenere all’Università di Harvard includono anche il concetto di leggerezza, che peraltro è il primo in ordine di apparizione.
Trattandosi di un discorso legato alle future possibilità nel campo della scrittura, in un contesto – quello del tardo Novecento – sempre più segnato da importanti trasformazioni culturali, Calvino la definisce in primis come una “sottrazione di peso” da applicare ai personaggi di una storia, alla sua struttura e al suo linguaggio, citando poi svariate opere letterarie da cui prendere spunto.
Ma è tutto qui? Certo che no: alcune riflessioni contenute in Lezioni americane sulla leggerezza prendono poi una piega meno tecnica e più suggestiva, arricchendosi di spunti di riflessione ancora molto attuali. Se vi interessa saperne di più, vi rimandiamo a questo nostro articolo che abbiamo dedicato più nel dettaglio all’argomento…
Fonte: www.illibraio.it